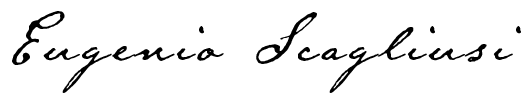Diritto e giustizia nel Magistero di Papa Francesco

La particolare attenzione del magistero di Francesco in favore delle persone più svantaggiate della società non poteva prescindere dalla sensibilizzazione delle varie istituzioni pubbliche a rafforzare lo stato di diritto, i diritti umani e la giustizia sociale, in modo da farsi “…promotrici di nuovi cammini di speranza verso un futuro più solidale, giusto e sereno per tutte le nazioni della terra…”. Il Pontefice ha esposto le sue riflessioni in più forme, sia nelle encicliche, sia nelle omelie, sia in interventi o saluti.
Con i limiti di ogni sintesi, quelle che seguono costituiscono gli elementi essenziali del pensiero di Francesco sui temi del diritto e della giustizia.
Lo stato di diritto
Nella piena consapevolezza delle sfide e delle difficoltà del tempo presente, con la centralità dei temi delle guerre, delle crisi climatiche, delle migrazioni, Francesco ha reclamato in più occasioni un cambio di mentalità auspicando una nuova costruzione dello stato di diritto. La forza del diritto – ha ammonito Francesco è la conditio sine qua non per raggiungere l’armonia sociale e la fratellanza universale, così da costruire un mondo dove prevalga non già “…il diritto del più forte, ma la forza del diritto”. Queste crisi, l’aumento delle violenze del mondo, le conseguenze del cambiamento climatico, la corruzione e le disuguaglianze non giustificano in alcun modo eccezioni all’applicazione dello stato di diritto, che è “…al servizio della persona umana e intende proteggere la sua dignità…”. Occorre, così, contrastare decisamente la tendenza, sempre più diffusa nelle democrazie, di una errata concezione della persona, che “…indebolisce la sua stessa protezione e apre progressivamente la porta a gravi abusi sotto l’apparenza del bene”.
Lo sviluppo di una coscienza democratica esige che si superino i personalismi e prevalga il rispetto dello stato di diritto, presupposto indispensabile per l’esercizio di ogni potere.

Lo stato di diritto deve essere garantito dalle autorità indipendentemente dagli interessi politici dominanti, nella certezza che quando esso si fonda su valori universali le persone hanno accesso alla giustizia e le società sono più stabili e prospere, poiché appartengono allo Stato le funzioni di pianificare, coordinare, vigilare e sanzionare, sul proprio territorio, “…gli utilizzi irresponsabili delle capacità umane…”. Lo strumento da utilizzare è il diritto, “…che stabilisce le regole per le condotte consentite alla luce del bene comune. I limiti che deve imporre una società sana, matura e sovrana sono attinenti a previsione e precauzione, regolamenti adeguati, vigilanza sull’applicazione delle norme, contrasto della corruzione, azioni di controllo operativo sull’emergere di effetti non desiderati dei processi produttivi, e intervento opportuno di fronte a rischi indeterminati o potenziali…”.

Peraltro, ha ricordato Francesco parlando alle Nazioni Unite (nel Settembre 2015), lo sviluppo e la promozione dello stato di diritto è legato a quello della limitazione del potere, che può esserlo efficacemente, affinché non leda in alcun modo alla dignità umana, solo attraverso l’implementazione dei diritti umani e la realizzazione di una reale giustizia redistributiva. In contrario il “dare a ciascuno il suo”, secondo la definizione classica di giustizia (del giurista Ulpiano, “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi”) diventa impossibile. Pertanto, pur nella consapevolezza della molteplicità e complessità dei problemi, più che spendersi nella redazione di buoni propositi – ammonisce Francesco – è sempre necessario rammentare come l’azione politica ed economica sia efficace solo quando è concepita come “…un’attività prudenziale, guidata da un concetto perenne di giustizia e che tiene sempre presente che, prima e aldilà di piani e programmi, ci sono donne e uomini concreti, uguali ai governanti, che vivono, lottano e soffrono, e che molte volte si vedono obbligati a vivere miseramente, privati di qualsiasi diritto.”
Una società senza diritto – ha ammonito Francesco citando il suo predecessore parlando ad un incontro formativo promosso dal Tribunale della Rota Romana nel Febbraio 2023 – sarebbe una società priva di diritti, “…perché il diritto è condizione dell’amore…” (Benedetto XVI, Lettera ai seminaristi, 18.10.2010). Pertanto, non bisogna mai perdere di vista i diritti, mettendo però al centro le persone, che sono soggetti e “oggetti” del diritto.
Solo il mantenimento dello stato di diritto, secondo Francesco, “…può svolgere un ruolo essenziale nella soluzione delle crisi globali, rinnovando la fiducia e la legittimità della governance pubblica, combattendo le disuguaglianze, promuovendo il benessere delle persone, favorendo la salvaguardia dei loro diritti fondamentali, incoraggiando la loro adeguata partecipazione al processo decisionale e agevolando lo sviluppo di leggi e politiche che soddisfino le loro reali necessità, contribuendo così a creare un mondo in cui tutti gli esseri umani siano trattati con dignità e rispetto”. Sicché, la raccomandazione per ogni struttura politica ed istituzione è sia di “…evitare le cattive pratiche…”, sia di “…incoraggiare le buone pratiche, per stimolare la creatività che cerca nuove strade, per facilitare iniziative personali e collettive.”
Elementi, valori e criteri indispensabili di uno stato di diritto, sono sinteticamente riepilogati da Francesco (Discorso ai partecipanti della IDLO, International Development Law Organization, Novembre 2023) nella “…adesione al principio di uguaglianza davanti alla legge, la prevenzione dell’arbitrarietà, la garanzia di trasparenza, la promozione di una partecipazione giusta nel processo decisionale, la salvaguardia del principio di sicurezza giuridica e il rispetto del giusto processo…”, elementi che, se implementati, hanno il potere di condurre alla realizzazione della giustizia, condizione senza la quale è impossibile raggiungere l’armonia sociale e la fraternità universale di cui l’umanità necessita.
La necessità di intervenire sulle regole per le condotte ha impegnato Francesco anche nell’amministrazione della giustizia nella Chiesa, riformando il Diritto Canonico sempre avendo come obiettivo “…la salvezza delle anime…” (legge suprema, come affermato nell’ultimo canone del Codice di Diritto Canonico, 1752) e di “…rendere un servizio alla verità…”, semplificando le procedure troppo complesse ricordando il monito ciceroniano “summum ius summa iniuria”. Soprattutto, raccomandando agli operatori di avere prudenza nell’applicare le norme, metodologia che “…richiede due grandi virtù: la prudenza e la giustizia, che devono essere informate dalla carità. C’è un’intima connessione tra prudenza e giustizia, poiché l’esercizio della ‘prudentia iuris’ mira alla conoscenza di ciò che è giusto nel caso concreto.” (Discorso alla Rota Romana, Gennaio 2024).
Giustizia e carità

Giustizia e carità devono procedere parallele. La giustizia non è astrazione, tantomeno utopia; né solo applicazione tecnica di un insieme di regole. È invece la virtù sociale per eccellenza per cui diamo a ciascuno ciò che gli spetta, indispensabile per il corretto funzionamento di ogni ambito della vita comune e perché ognuno possa condurre una vita serena. Francesco lo ha sempre ricordato in occasione di varie inaugurazioni degli anni giudiziari del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e spesso ha richiamato la Caritas in veritate, dove Benedetto XVI scriveva che la giustizia è la prima via della carità e misura minima di essa (come aveva ammonito Paolo VI), costituendo, insieme al bene comune, criterio orientativo dell’azione morale. Entrambi, giustizia e bene comune, sono fondamentali per lo sviluppo in una società in via di globalizzazione.

Anche Francesco ha ricordato l’antico brocardo ubi societas, ibi ius: ogni società elabora un proprio sistema di giustizia. La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all’altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Ma non è possibile “donare” all’altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Nell’Amoris Laetitia Francesco scrive come occorra “…sviluppare l’abitudine di dare importanza reale all’altro…di dare valore alla sua persona, di riconoscere che ha diritto di esistere, a pensare in maniera autonoma e ad essere felice…”.

Chissà se, in questa parte del loro magistero, gli ultimi due pontefici abbiamo voluto riportarci ad Aristotele ed alla sua Etica Nicomachea, con la caratterizzazione della giustizia πρός έτερον (pròs èteron), ad alterum, come poi dirà anche San Tommaso. La giustizia ha a che fare con l’altro, è uno dei modi dell’incontro con l’altro, dell’esse ad, dell’essere-in-relazione, dell’essere-con. La Giustizia, come virtù, è dunque un modo di relazione, implicando un rapporto con l’altro. Appartiene proprio a San Tommaso la definizione della giustizia come “…volontà perpetua e costante di rendere a ciascuno il suo diritto” (Perpetua et costans voluntas jus suum cuique tribuendi…): la giustizia è la virtù che ci porta a riconoscere a ciascuno ciò che gli spetta, ciò che è “suo”.

Se amare è donare, chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro. Dunque, la giustizia non solo non è estranea alla carità, né una via alternativa o parallela, ma è “…inseparabile da essa e parte integrante di quell’amore, con i fatti e nella verità, esortato dall’apostolo Giovanni (1 Gv., 3, 18)…”. E se da una parte, la carità esige la giustizia, cioè il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli individui e dei popoli, adoperandosi per la costruzione della “città dell’uomo” secondo diritto e giustizia; dall’altra, la carità supera la giustizia e la completa nella logica del dono e del perdono. La “città dell’uomo” non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. Perché – precisa Francesco – la carità manifesta sempre anche nelle relazioni umane l’amore di Dio, così conferendo valore teologale e salvifico a ogni impegno di giustizia nel mondo.
La costruzione ed il corretto funzionamento della “città dell’uomo” richiede, insieme alla giustizia, la ricerca del bene comune. È necessario amare, volere il bene e adoperarsi efficacemente per esso. Sia il bene individuale, verso qualcuno, sia il bene legato al vivere sociale delle persone, il bene comune. È il bene – ricorda Francesco richiamando la Gaudium et spes – di quel noi-tutti formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale. Non un bene fine a sé stesso, ma ricercato per le persone che fanno parte della comunità sociale e che solo in essa possono realmente e più efficacemente conseguire il loro bene.

Il bene comune
per la edificazione della città dell’uomo
Nel declinare gli elementi caratterizzanti la ricerca del bene comune, necessari alla edificazione della “città dell’uomo”, Francesco li individua nella umanità, nella ospitalità, nell’accoglienza, nell’attenzione e generosità verso chi è in difficoltà, nel “…collaborare con spirito costruttivo e solidale, per il bene di tutti.”
Francesco collega la nozione di bene comune, cioè “…di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente…”, a questa più ampia di sviluppo integrale della persona umana.

Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene comune è prendersi cura, da una parte, e avvalersi, dall’altra, di quel complesso di istituzioni che strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo prende forma di pólis, di città. Ogni cristiano – ammonisce Francesco – è chiamato a questa carità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella pólis.
Mentre molti credenti dubitano ancora della importanza dell’impegno attivo nella vita istituzionale e politica, Francesco, invece, sottolinea come questa esigenza di incidere nella pòlis sia parte della carità; anzi, via non meno qualificata e incisiva di quanto lo sia la carità che incontra il prossimo direttamente, fuori delle mediazioni istituzionali della pólis. Se animato dalla carità, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e politico. Perché come ogni impegno per la giustizia, esso s’inscrive in quella testimonianza della carità divina che, operando nel tempo, prepara l’eterno.

Francesco non manca di rammentare come presenza ed azione dell’uomo, se ispirate e sostenute dalla carità, contribuiscano all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana. Così, in una società sempre più globalizzata, il bene comune e l’impegno devono assumere le dimensioni dell’intera famiglia umana, estesa alla comunità dei popoli e delle Nazioni, come già raccomandato da Giovanni XXIII con la sua Pacem in Terris, così da dare forma di unità e di pace alla città dell’uomo, e renderla in qualche misura anticipazione prefiguratrice della città senza barriere di Dio.
Ad ulteriore specificazione, deve annotarsi come questa visione della costruzione della casa comune di tutti gli uomini si regge anche sulla comprensione di una certa sacralità di tutto il creato. Circostanza che, a maggior ragione, “…impone un grado superiore di saggezza, che accetti la trascendenza – quella di sé stesso –, rinunci alla costruzione di una élite onnipotente e comprenda che il senso pieno della vita individuale e collettiva si trova nel servizio disinteressato verso gli altri e nell’uso prudente e rispettoso della creazione, per il bene comune…”. Perché, ripetendo le parole di Paolo VI (dal Discorso alle Nazioni Unite, Ottobre 1965), “…l’edificio della moderna civiltà deve reggersi su principii spirituali, capaci non solo di sostenerlo, ma altresì di illuminarlo e di animarlo.”
Il rapporto tra giustizia e diritto
Se la giustizia consiste nel dare a ciascuno il suo si rileva immediatamente come per dare a ciascuno il suo sia necessario che prima si definisca cosa spetti a ciascuno, e dunque prima della giustizia viene il diritto, ciò che spetta.
“Suo” – quale riconoscimento basilare della giustizia – non è semplicemente ciò che è unito al soggetto mediante una relazione oggettiva di possesso; è piuttosto la coscienza e la consapevolezza di tale possesso; è un modo dell’essere-sé, un’esperienza intrasoggettiva di ciò che si possiede o che si deve possedere.
In questo senso, rendere a ciascuno il suo è anche rendere a ciascuno la coscienza di sé, dunque la libertà: volere rendere a ciascuno ciò che è suo, in fondo, è innanzitutto volere che ciascuno sia sé stesso, cioè che sia libero.
Nell’ordine pratico, la prima manifestazione della giustizia – l’imprescindibile condizione del suo manifestarsi – è perciò la libertà. La volontà costante e perpetua di rendere a ciascuno il suo diritto è, innanzitutto, volontà costante di riconoscergli il diritto alla libertà, primo fondamento di ogni relazione tra gli uomini, precondizione dell’eguaglianza: quest’ultima – e con essa la virtù della giustizia chiamata a garantirne la realizzazione – non potrebbe neppure ipotizzarsi senza il riconoscimento della reciproca libertà, fondamento per la convivenza pacifica nella società.
La relazione umana si struttura tra eguali – e può dunque configurarsi come “giusta” – solo se gli “eguali” sono, innanzitutto, egualmente liberi. Dunque, la giustizia è virtù fondata sulla costante autolimitazione, per garantire, innanzitutto, a ciascun altro di essere sé stesso, di essere libero. Il suo fine, ha sottolineato Francesco in occasione di una catechesi sulla giustizia (udienza generale del 3 Aprile 2024) “…è che in una società ognuno sia trattato secondo la sua dignità. Ma già gli antichi maestri insegnavano che per questo sono necessari anche altri atteggiamenti virtuosi, come la benevolenza, il rispetto, la gratitudine, l’affabilità, l’onestà: virtù che concorrono alla buona convivenza delle persone. La giustizia è una virtù per una buona convivenza delle persone.”
Questa idea di giustizia è al centro dell’attenzione di Bergoglio sul tema del cambiamento climatico, definita “…questione di giustizia internazionale…”.
Sono state tantissime le occasioni in cui, dopo aver accusato come il degrado del pianeta impedisca una convivenza serena e armoniosa sia del tempo presente, sia in larga misura del progresso integrale delle future generazioni, Francesco ha chiesto applicarsi “…un approccio di giustizia all’azione climatica”, in modo da “…fornire risposte olistiche, inclusive e eque”.

La preoccupazione sempre emergente di Francesco è stata quella di sensibilizzare al rispetto delle persone e dei diritti umani, da anteporre a tutto. Perché l’uomo, “…creatura di questo mondo, ha diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha una speciale dignità…”. È questa la motivazione prima della criticità verso l’attuale modello di sviluppo e della ferma condanna della sostanziale mancanza di tutele per le vittime di ogni specie di sopruso, di violenza, di negligenza, di omissioni, mancanza che aumenta quella cultura dello scarto da contrastare in ogni contesto e soprattutto garantendo diritti agli ultimi, agli indifesi, ai soggetti deboli, titolari anche loro di diritti da rispettare. Sullo sfondo, la mai celata accusa verso un sistema economico e sociale che – accusava Francesco parlando ai membri dell’Unione dei Giuristi Cattolici nel Dicembre 2021 – “… finge di includere le diversità ma che di fatto esclude sistematicamente chi non ha voce…”, con grave pregiudizio per i diritti dei lavoratori, dei migranti, dei malati, dei bambini non nati, delle persone in fin di vita e dei più poveri, diritti “…sempre più spesso trascurati e negati in questa cultura dello scarto…”, in un contesto in cui “…chi non ha capacità di spendere e di consumare sembra non valere nulla”.
Il riconoscimento dei diritti delle persone più deboli per Francesco non deriva da una “concessione governativa”, bensì dal superiore riconoscimento della dignità umana. Ed ecco il richiamo al ruolo dei giuristi, consulenti, avvocati o giudici che siano: contribuire alla tutela della dignità umana dei deboli affermando i loro diritti, così da contribuire all’affermarsi della fraternità umana e a non deturpare l’immagine di Dio impressa in ogni persona.

“Per la Santa Sede – esordì Francesco parlando al Corpo Diplomatico nel Gennaio 2018 – parlare di diritti umani significa anzitutto riproporre la centralità della dignità della persona, in quanto voluta e creata da Dio a sua immagine e somiglianza”.
Senza tener conto di questo, oltre che dell’affermazione secondo cui “…i diritti traggono il loro presupposto dalla natura che oggettivamente accomuna il genere umano…”, tutto il magistero di Francesco, spesso compendiato nella cultura dello scarto, non si coglie in modo corretto. E nella parola “natura” va rilevato un riferimento a quella legge naturale che dovrebbe essere il fondamento pre politico a qualsivoglia diritto positivo.
La relativizzazione ideologica intervenuta nel corso degli anni – ammoniva Francesco nella stessa occasione – ha modificato l’interpretazione di alcuni diritti, includendone una molteplicità di “nuovi” molto spesso in contrapposizione tra loro, “…frutto di una visione riduttiva della persona umana, che sempre più spesso constatiamo in quella cosiddetta dittatura dei desideri che spesso fa capolino come ratio in molte norme delle società secolarizzate…”.

Su questi presupposti dottrinali, risulta alquanto stucchevole la polemica che ha accompagnato le dichiarazioni di Francesco sulla tema della proprietà privata in occasione di un breve video messaggio ai giudici dei comitati per i diritti sociali di Africa e America nel 2020, peraltro riprendendo quanto aveva scritto nella enciclica Laudato si’ nel 2015: “La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile il diritto alla proprietà privata e ha sottolineato sempre la funzione sociale di ciascuna delle sue forme. Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario derivante dal diritto che hanno tutti, nato dalla destinazione universale dei beni creati. Non c’è giustizia sociale che possa cementarsi sull’iniquità, che comporti la concentrazione della ricchezza.”

Occorre, invero, rammentare come il messaggio fosse indirizzato a mondi, come l’America e l’Africa, nei quali non ovunque i diritti umani, i diritti fondamentali e i diritti sociali sono tenuti in massima considerazione. Peraltro, la Chiesa ha sempre insegnato che il diritto di proprietà è correttamente inteso se è posto a fondamento tanto del bene individuale, quanto del bene comune e che, inoltre, il diritto di proprietà è da inscriversi nell’alveo del (dimenticato) diritto naturale: per quanto esso possa e debba essere tutelato, non si può mai utilizzare contro la dignità della persona, poiché è il diritto di proprietà per l’uomo e non l’uomo per il diritto di proprietà. Ed è parso invero sgradevole non tener conto di come proprio nella Laudato si’ Francesco – in piena sintonia con il magistero della Chiesa – abbia confermato la piena legittimità del diritto di proprietà, se utilizzato in vista di quella superiore istanza etica che è il bene della persona umana (L.S, 93 – 94).
Rispetto della legge e fare giustizia.
Il ruolo dei giudici.
Realizzare e stabilire la giustizia, fondamentale per la convivenza pacifica nella società, richiede leggi che rispettino i diritti. In mancanza non può esservi ordine, né sviluppo sostenibile e integrale, né tantomeno pace sociale.
Nel magistero di Francesco il “fare giustizia” non equivale certo a cercare il castigo per sé stesso, come spesso ha ricordato specialmente ai giudici, ma a fare in modo che, occorrendo attribuire una pena, questa tenda alla rieducazione dei responsabili, in modo che si possa aprire loro una speranza di reinserimento nella società. Perché non può esserci valida pena senza speranza. Ed i giudici sono chiamati a dare speranza nel fare la giustizia (“… peregrinantes in spem…”, così Francesco rivolge loro il suo saluto), aiutando a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali. In ogni contesto. Con un lavoro che non finisce certo con la sentenza, ma continua, in modo che ci sia un accompagnamento, una crescita, un reinserimento, una riabilitazione della vittima e del carnefice. Un lavoro che è anch’esso di vero servizio in favore delle persone e del bene comune.

Fare giustizia richiede un equilibrato e sapiente discernimento, così da aprire anche alla misericordia. Perché, ricordando San Tommaso d’Aquino (secondo cui “…la misericordia non toglie la giustizia, ma è una pienezza della giustizia…”), la misericordia non solo non esclude la giustizia e la verità, ma vieppiù è essa stessa “…la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità…” in quanto manifestazione della misericordia divina (Amoris Laetitia, 311), in coerenza con la dignità trascendente dell’uomo, che rimanda “…alla sua natura, alla sua innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella ‘bussola’ inscritta nei nostri cuori e che Dio ha impresso nell’universo creato.” (Discorso al Parlamento Europeo, Novembre 2014).
In modo particolare ai giudici, dunque, Francesco raccomanda di “…operare con amore verso la persona giudicata, compito tanto più lieve quanto più il giudice avverta con umiltà le proprie debolezze, quanto più si ripresenterà ogni volta alla società disposto e proteso a comprendere l’uomo che ha di fronte e a giudicarlo senza atteggiamento da superuomo, ma anzi con costruttiva contrizione.” (Discorso ai membri del Centro Studi Rosario Livatino, Novembre 2019).
La giustizia del caso concreto.
Francesco ha esplicitato la missione degli operatori del diritto come non limitata al mero uso positivistico delle norme in cerca di soluzioni di comodo ai problemi giuridici o tentare “equilibrismi”. In questo modo, ci si porrebbe al servizio di qualsiasi interesse, oppure si intrappolerebbe la vita in rigidi schemi formalistici e burocratici che trascurano i veri diritti. Invece, ammonisce Francesco, “…la realtà è superiore all’idea, il ‘concreto’ della vita è superiore al formale, sempre; la realtà è superiore a qualsiasi idea, e questa realtà va servita con il diritto.”

Pertanto, la grandezza del compito del giurista sta non già nella rigida applicazione della normativa, ma nel “…non dimenticare l’equità del caso singolo, compito che può essere attuato solo attraverso le virtù della prudenza giuridica che discerne il giusto concreto. Arrivare dall’universale all’universale concreto e al concreto: ecco una via di saggezza giudiziaria. Un giudizio o un aiuto giudiziario non si fanno con equilibri o squilibri, si fanno attraverso questa saggezza. Ci vuole scienza, ci vuole capacità di ascolto…”. Sarebbe errato considerare la raccomandazione successiva di Francesco come riservata ai soli operatori della giustizia canonica; perché quello del “…ci vuole preghiera per giudicare bene…” è il sommo umile affidamento di ogni giurista perché “…non si trascurano né le comuni esigenze di bene comune inerenti alle leggi né le dovute formalità degli atti, ma tutto si colloca entro un vero ministero di giustizia.”
In questo percorso di ricerca di equità si manifesta la vera giustizia della Chiesa, animata dalla carità e temperata dall’equità, così qualificandone la pastorale. Se, in questo, Francesco si rifà all’insegnamento di Giovanni Paolo II (Discorso alla Rota Romana, Gennaio 1990), l’annotazione di Francesco appare tipica del suo magistero, con una Chiesa sempre “…in mezzo al gregge, con l’odore del gregge e cercando il progresso del gregge.”

Il testamento di Francesco
Questi dodici anni di pontificato affidano a tutti gli operatori del diritto, anche non credenti – questi ultimi certamente affascinati dalle specifiche aperture di Francesco proprio verso l’intera parte del “gregge”, senza alcuna esclusione –, ad affermare e tutelare i diritti dei più deboli, all’interno di un sistema economico e sociale che finge di includere le diversità ma che di fatto esclude sistematicamente chi non ha voce.
L’efficace contrasto alla “cultura dello scarto” richiede cura ed attenzione verso i diritti dei lavoratori, dei migranti, dei malati, dei bambini non nati, delle persone in fin di vita e dei più poveri. Al contrario, negare i diritti fondamentali, negare il diritto ad una vita dignitosa, a cure fisiche, psicologiche, spirituali, significa negare la dignità umana.
Ad ogni operatore del diritto compete contribuire alla tutela della dignità umana dei deboli tutelando i loro diritti. Solo in questa maniera si concorre all’affermarsi della fraternità umana e a non deturpare l’immagine di Dio impressa in ogni persona, cooperando a costruire una società più umana e più giusta.
Non da ultimo, ci resterà la raccomandazione che Francesco indica nelle parole del profeta Isaia e riferite al Servo del Signore: “Proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra.” (Is., 42,3-4). Il Messia annunciato, ha a cuore il diritto e la giustizia; Gesù Cristo, nella sua missione terrena, si è rivolto a tutti, senza esclusioni; ad ognuno di noi il compito di attuare, con concreta praticità, un mondo di uguali. Auspicio, speranza o utopia che sia, è bene quantomeno provarci.
(pubblicato nella rivista Vivere In, 2 – 2025, pagg. 15 – 23)