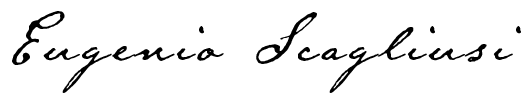La forza della spada, l’equilibrio della bilancia

Dipinto murale: Il giudizio di Re Salomone, di Giambattista Tiepolo
Museo Diocesano d’Arte Sacra e Galleria del Tiepolo
Prendere parte al vulcanico confronto sulle spese militari non ci appassiona. Perché esprimere opinioni sul delicato equilibrio della bilancia delle spese dello Stato, tra bisogni, insoddisfazioni, priorità, limitatezza di risorse, scelte da fare, è estremamente complicato.
Tutti vorremmo che cessino guerre e corsa agli armamenti, con destinazione delle relative risorse alle esigenze dello stato sociale. Ma, questa, è una delle più chimeriche tra le utopie del possibile.
La difesa dello Stato e della sovranità nazionale, che nell’età contemporanea assume connotazioni ed interessi ben oltre i confini nazionali ed in parte delegate e condivise con organismi sovrastatali, rende estremamente complesse e scomode riflessioni già di per sé problematiche.
Ed ecco che, mentre il dibattito si accalora, sovviene un ricordo. Quello raccontato nel Libro dei Re (3, 16 – 28) e riguardante un celebre giudizio richiesto al re Salomone e riguardante l’attribuzione della maternità di un bambino ad una delle due pretese madri.
Questo il racconto.

Un giorno vennero dal re due prostitute e si presentarono innanzi a lui.
Una delle due disse: «Perdona, mio signore! Io e questa donna abitiamo nella stessa casa; io ho partorito mentre lei era in casa. Tre giorni dopo il mio parto, anche questa donna ha partorito; noi stiamo insieme e non c’è nessun estraneo in casa fuori di noi due. Il figlio di questa donna è morto durante la notte, perché lei gli si era coricata sopra. Ella si è alzata nel cuore della notte, ha preso il mio figlio dal mio fianco, mentre la tua schiava dormiva, e se lo è messo in seno e sul mio seno ha messo il suo figlio morto. Al mattino mi sono alzata per allattare mio figlio, ma ecco, era morto. L’ho osservato bene al mattino; ecco, non era il figlio che avevo partorito io».
L’altra donna disse: «Non è così! Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto».
E quella, al contrario, diceva: «Non è così! Quello morto è tuo figlio, il mio è quello vivo».
Discutevano così alla presenza del re.
Il re disse: «Costei dice: «Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto», mentre quella dice: «Non è così! Tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo»».
Allora il re ordinò: «Andate a prendermi una spada!».
Portarono una spada davanti al re.
Quindi il re aggiunse: «Tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all’una e una metà all’altra».
La donna il cui figlio era vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: «Perdona, mio signore! Date a lei il bimbo vivo; non dovete farlo morire!».
L’altra disse: «Non sia né mio né tuo; tagliate!».
Presa la parola, il re disse: «Date alla prima il bimbo vivo; non dovete farlo morire. Quella è sua madre».
Il racconto si conclude con la precisazione che, resa pubblica la notizia del giudizio del re, tutti ne provarono profondo rispetto, avendone constatato la saggezza nel rendere giustizia.

«Andate a prendermi una spada!… Tagliate in due il bambino vivo…».
Più che l’ordine impartito dal re, dal racconto emerge il valore simbolico dell’invocare e mostrare la spada, la cui forza e persuasione si appalesano anche ed ancor meglio se viene sì mostrata, ma non utilizzata. Come accade per il diritto, con i consociati che sanno che esso, applicate le norme attraverso l’amministrazione della giustizia, esiste, vige, non conosce ignoranza, silenzioso strumento di deterrenza. Può non accadere, ma c’è, intervenendo risolutore nei casi estremi.
È sufficiente un ordine, preciso, secco, determinato, a risolvere l’intricata controversia. Controversia angosciosa, per certi aspetti; tanto da richiedere un ordine altrettanto tragico e doloroso. Quell’ordine di Salomone, «…Andate a prendermi una spada!…», incute timore nel giusto, ma risolve la contesa a suo favore a scapito del calunnioso.
La spada, invocata e mostrata, dissuade e disorienta.
È strumento che provoca dolore, simbolo di forza, di autorità, di punizione inesorabile.
Visibile e palese, è per questo ben più potente ed efficace del pugnale, che appare piuttosto simbolo di nascondimento e di colpo a sorpresa.
Della sua deterrenza scrive anche San Paolo (Rom. 13, 4), che rammenta come l’autorità vada temuta non se si fa il bene, ma se si fa il male, “…perché non invano essa porta la spada…”.
Evoca il giudizio severo ed ultimo, il decidere, cioè – anche etimologicamente, de caedere ossia il tagliare da – il separare, tagliare ed asportare la parte scorretta o malata per poter risolvere e guarire il tutto. Taglia perché vuol mettere la parola fine.
Lo storico dell’arte Ernst Hans Gombrich, commentando la Iustitia affrescata da Raffaello Sanzio (tra il 1509 ed il 1511) nella Stanza della Segnatura nei Musei Vaticani, già luogo supremo dell’esercizio del potere giudiziario papale, in cui la figura della Giustizia, seduta su un trono di nubi e circondata da putti reggenti il motto «ius suum cuique tribuit» (a ciascuno il suo diritto), oltre alla bilancia nella mano sinistra, impugna la spada nella destra, ebbe occasione di precisare come la spada sguainata fosse simbolicamente volta non tanto ad essere brandita come arma, quanto piuttosto ad ammonire.

Così, nell’opinione di Gombrich, la Giustizia di Raffaello può interpretarsi sia come virtù cardinale che punisce e difende, sia come «…personificazione che presiede agli studi di diritto…». Tanto, anche in relazione alla collocazione dell’affresco proprio nella Stanza della Segnatura, interamente consacrata alle arti del sapere, divino, razionale e giuridico.
Per quanto immagine autonoma e simbolica ex sé, la spada si accompagna e quasi previene l’azione valutativa dalla bilancia, cui si accompagna nella iconografia della Giustizia. Come la bilancia, allude anche i doppi lati della giustizia: il rigore e la clemenza, il diritto e l’equità, la lettera della legge ma anche i valori a cui si ispira, la legge ma anche la sua interpretazione secondo i principi superiori dell’ordinamento, in equilibrata connessione.
Accostare la spada alla bilancia, simbolo di equilibrio per antonomasia, esprime che della prima può evitarsi l’utilizzo se solo, con saggezza, la si mostri in modo opportuno.
Lo evidenzia anche il giurista Rudolf von Jhering, che nella sua opera più famosa, La lotta per il diritto, pose in rilievo l’essenza del diritto in coincidenza con la lotta.


L’obiettivo del diritto è di garantire e mantenere la pace, ma la sua affermazione avviene attraverso la lotta. Lotta tra individui, tra popoli, tra uno o più individui e organizzazioni, anche statuali. Tant’è, afferma von Jhering, che la Giustizia è raffigurata con in mano la bilancia e la spada. La bilancia suggerisce l’idea dell’equilibrio, dell’equità e della saggezza; la spada richiama l’idea della forza. È la forza di chi, singolo o comunità, si ritiene danneggiato e deve mostrare per poter per affermare il proprio diritto. Al tempo stesso, è anche la forza che la stessa Giustizia deve utilizzare per imporre i propri giudizi e farli rispettare.

Spada e bilancia sono entrambe necessarie: uno Stato di diritto si ha solo quando la forza, con la quale la Giustizia manovra la spada, uguaglia l’abilità con cui essa bilancia i diversi interessi (diritti) che si contrappongono.
L’unione tra spada e bilancia nella raffigurazione della Giustizia appare particolarmente significativa in un’illustrazione xilografica che compare in un romanzo allegorico scritto da vari autori, stampato nel 1499, intitolato Hypnerotomachia Poliphili (Combattimento amoroso di Polifilo in sogno), corredato da 169 illustrazioni.

La spada, rivolta verso l’alto, fa da asse della bilancia, formando una croce che, rimandando al divino, dà un’idea di armonia e di ordine. Spada e bilancia vengono così presentati come un unicum.
Questa protagonista indiretta dell’episodio di Re Salomone, come raccontato nel Libro dei Re, la spada, genera – dunque – diverse considerazioni.
Da un canto, quella che la presenza delle armi genera una qualche forma di persuasione. Non è detto che vadano utilizzate; ma può essere opportuno il mostrarle. Meglio, certo, se con prudenza e cautela. Lo sanno bene nei regimi dittatoriali, dove l’interesse maggiore delle parate militari è costituito non dai rappresentanti delle diverse forze armate, ma dai loro armamenti. E lo sanno ancor meglio quei Capi di Stato che, indistintamente, minacciano l’apertura delle porte degli arsenali atomici ed espongono propagandisticamente esperimenti e risultati ottenuti.
D’altro canto, ancor più, dal racconto della spada di Re Salomone emerge proprio la figura del saggio Re. Silenzioso, ascolta la discussione, lascia scatenare la foga delle contendenti; poi dispone con poche misurate equilibrate parole. Soprattutto, con risoluta praticità, agisce: mostrando la spada, con la mera esibizione, risolve la contesa. Quel re opera con equilibrio, saggezza e ragionevolezza. Con attento discernimento e prudente giudizio, rende illuminata giustizia.
Ancora una volta, e per altro verso, emerge la bontà della ricerca della “terza via”, della giusta ponderazione dei diversi conflitti per dirimerli con equità.
Quel racconto ci consegna un’immagine di straordinaria efficacia. Quella della spada che, equamente accompagnata e contemperata dalla bilancia, la saggezza del Re, diventa strumento di somma giustizia.

(pubblicato nella rivista “Vivere In”, 6/2024, 12 – 15)