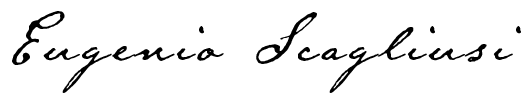Tempo di leggi o di valori?

Se lo chiedeva il poeta latino Orazio più di duemila anni fa (“Quid leges sine moribus, vanae proficiunt?”, Odi, III, 24, 35 – 36).
Per quanto in parte condizionata da propaganda augustea, nell’ode emerge il sensibile interesse per il tema della responsabilità del cittadino Orazio nell’affrontare un grande tema civile e morale.
Mezzo secolo prima, il tragediografo greco Sofocle già proponeva, nella sua Antigone, il tema del rapporto tra obbligo giuridico ed obbligo morale, presentando il caso dell’inottemperanza all’obbligo derivante dal comando legale umano (il divieto di sepoltura) in virtù della superiorità di un ordine morale di origine divina.
Che il tema fosse attuale e dibattuto già a quel tempo, è testimoniato anche dalla sua centralità nel Prometeo incatenato di Eschilo, rappresentazione del ribelle che, non accettando l’ordine imposto dal nuovo sistema (la volontà di Zeus e dei nuovi dèi rispetto ai titani), ne sfida la volontà proponendosi come portatore di un valore capace di suscitare la simpatia del lettore: la solidarietà verso gli uomini, aiutandoli a progredire facendo loro conoscere il fuoco.
Il tema ha origini antichissime, pari a quelle dell’umana esistenza.
Quell’interrogativo oraziano ha prodotto, nel corso dei secoli, un vivace confronto culturale sulla fonte dell’obbligo giuridico, sulla sua natura, sulla sua efficacia, sui suoi effetti. Più in generale, il dibattito verte proprio sul rapporto tra obbligo giuridico ed obbligo morale e si ripropone e si sviluppa, quasi ciclicamente, ogni qual volta la coscienza sociale si interroga rispetto ai nuovi fenomeni ed esigenze che sempre la storia produce.
Accade, proprio in questi giorni, riguardo il complesso fenomeno della immigrazione, che anima i dibattiti politici – e, dunque, legislativi – nel nostro Paese e nell’area mediterranea, come anche negli Stati Uniti e Medio Oriente.
Le cronache mediatiche, nelle quali primeggia un certo uso accalorato dei social , ci offrono la semplificazione di quell’ampio dibattito culturale, riducendolo a tifo politico tra opposti. Qualcuno azzarda equiparare ogni moderno novello disubbidiente ad Antigone, dimenticando come alla protagonista sofoclea non interessasse certo sollevare un caso politico, quanto esaltare il sentimento amoroso, il senso del rispetto della famiglia e del corpo del fratello morto. “Non per condividere odio, ma per condividere l’amore sono nata” , precisa Antigone al tiranno Creonte.
La chiave di lettura di quella storia sta nell’amore, la nuova proposta che, dirompente, si propone quale valore ispiratore di condotte nella storia degli uomini.
In un contesto storico – sociale che vedeva ancora primeggiare il valore della virtù eroica e guerriera, accompagnata dalla capacità oratoria, si affacciava la nuova prospettiva di vita, quel potente impeto in grado, specificherà Platone, di “mettere le ali all’anima”.
L’amore, in tutte le sue possibili declinazioni, supera e va ben oltre la politica, al contempo ben potendola orientare. All’opera paziente e mediatrice della politica è affidata la civile convivenza, con il suo fine ultimo di disciplinarla e, così, governarla. Ai tanti protagonisti dell’attività politica, a vario titolo e livello, è affidata la paziente ricerca, nello svolgersi della storia, del punto di equilibrio tra la correttezza delle scelte, tipiche e riservate a questa specifica e nobile attività umana, e la strumentalizzazione, l’uso improprio, estraneo, come puro mezzo, dei valori di fondo sottesi da quelle scelte.
La complessità del fare politica consiste nell’individuare ed esplicitare in maniera corretta il contenuto valoriale cui riferirsi nell’elaborare una regola, una norma: in uno, nel disciplinare la nostra vita. Vale sia per le norme a validità generale, la cui individuazione è riservata ai vari parlamenti, sia per le più comuni regole di vita, finanche familiari, che ogni genitore prova a fissare per i propri figli.
Non è facile trasformare i valori di riferimento in regole, facendone azioni e condotte di vita.
A monte, ancora più, non è affatto facile la scelta, tra quelli possibili, dei valori cui riferirsi.
Eppure, prima ancora che leggi e regole, servono valori, senza i quali delle prime rimarrebbe il solo imperativo del comando, spesso incomprensibile. Perché mai, infatti, dovremmo osservare una legge, obbedire al suo comando, se non ne condividiamo il valore che esso sottende? Forse perché è forte e presente in noi, sia pur la non condivisione del valore, il senso dello Stato? E piuttosto, perché non dovremmo lavorare ed adoperarci, per favorire, maturare e condividere, tutti ed ognuno, valori comuni? E quali possono essere questi valori comuni cui ispirarsi?
Un valore, una regola, ha assunto, nel corso della storia, dignità di regola aurea : l’amore. L’amore, è la legge suprema cui ispirarsi, come a noi consegnata in due massime. La prima è quella del non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te.
Il testo evangelico (Mt. 7,12; Lc. 6, 31) non si esprime in termini negativi, ma positivi, fate agli altri ciò che volete vi sia fatto. Il senso positivo, introdotto da Gesù rispetto alla precedente versione, più antica e già conosciuta nel Vecchio Testamento (Tb. 4, 15), conferisce alla massima un significato di ben maggiore esigenza e portata.
La seconda è quella dell’ ama il prossimo tuo come te stesso (Lev. 19, 18).
In entrambe le massime, pur nella versione negativa della prima, si coglie il senso più vero dell’autentica morale cristiana, che esige l’attivo e positivo intervento: amare significa agire in favore dell’altro, opera realizzatrice, pratica e concreta, del più ampio ed infinito Amore divino (Gv. 15, 9 – 17).
L’essenza dell’amore è la dinamica tensione verso l’altro, in un percorso solidale che guardi alla comunanza della mia vita con la tua.
Non è tempo di una rigida produzione giuspositivistica, tra previsioni, elencazioni e specificazioni; è tempo di individuare ed esaltare valori universali. Tra questi, occorre scegliere e spendersi perché la regola aurea dell’amore diventi ethos comune, un indirizzo, un valore, riferimento universale, naturale, pur non codificato, ma tuttavia nucleo centrale della costruzione di una nuova società civile.
Non servono leggi speciali; non servono lunghi discorsi, né gran numero di precetti. Serve aprire il cuore degli uomini a valori superiori, trascendenti, cioè in grado di andare oltre il conosciuto aprendosi ad ogni nuova epifania storico – sociale. Soprattutto, serve fare della regola aurea dell’amore valore primario di riferimento, conferendo ad essa dignità di legge scritta nei cuori. Perché è quella regola aurea, il comandamento dell’amore, come proposto e spiegato nei vangeli e nella tradizione cristiana successiva, che, se assurto a fonte primaria di etica di vita, è in grado di illuminare e – se necessario – superare le leggi scritte degli uomini.
Se compito della politica è il disciplinare la nostra vita, ad ognuno di noi, protagonisti e destinatari del suo percorso, complesso e variegato, compete indirizzarla eticamente. Cominciando dal chiederci a quali valori intendiamo ispirare le nostre condotte di vita; poi facendo in modo che quei valori siano sempre più condivisi e si trasferiscano materialmente anche nelle regole scritte del mondo civile, la cui elaborazione diventa sempre più complessa e sofferta, terreno di scontri che spesso finiscono con il limitare e pregiudicare la dignità della persona umana, immagine del Supremo Amore in terra.