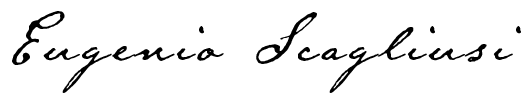Che sia in politica o nella vita, il fine giustifica i mezzi?

Una questione con la quale tutti, nessuno proprio escluso, che la si ponga come interrogativo o come soluzione, prima o poi ci confrontiamo: “Il fine giustifica i mezzi”.

La frase viene attribuita a Niccolò Machiavelli, che in verità non l’ha mai pronunciata, appartenendo al critico letterario Francesco de Sanctis con riferimento ad interpretazioni fuorvianti del pensiero di Machiavelli espresso ne Il Principe, nel quale si teorizzava il fatto che qualsiasi azione sarebbe giustificata, anche se in contrasto con le leggi della morale.

Nato il 3 maggio 1469 e scomparso il 21 giugno del 1527 a Firenze, lo scrittore, storico, statista e filosofo italiano Niccolò Machiavelli è indubbiamente uno dei più importanti personaggi della storia della letteratura. Il suo testo più famoso, Il Principe, fu scritto nel 1513, plasmato dallo specifico contesto storico in cui visse, fra Quattrocento e Cinquecento, tra guerre ed instabilità politica. Pone riflessioni importanti e viene studiato ancora oggi per alcune intuizioni sulla natura del potere e del governo. Soprattutto, emerge l’importanza del pragmatismo e della separazione della politica dalla morale e dalla religione. Perché giustifica chi detiene il potere, nella forma di repubblica o di principato, a ricorrere a tutti i mezzi per garantire il benessere e l’integrità dello Stato. L’obiettivo ultimo sarebbe nobile, riconoscendo all’attività politica un compito molto alto ma tutto terreno: dare agli uomini istituzioni atte a garantire loro un buon ordine civile.
Ne Il Principe, dedicato a Lorenzo de’ Medici, l’Autore si pone il compito di analizzare come si possa fondare e mantenere uno Stato nuovo, moderno, durevole. In esso, il principe è visto come un eroe politico, in grado di fondare e difendere uno Stato nuovo. Come esempio, Machiavelli sembra indica il tiranno Cesare Borgia, figlio del papa Alessandro VI, cui dedica il VII capitolo del libro.
La frase “il fine giustifica i mezzi” sintetizza e si riferisce espressamente ad azioni legate alla ragion di Stato. All’interno del capitolo XVIII de Il Principe, Machiavelli spiega come esistano due diversi modi di governare: quello dell’uomo e quello della bestia. L’uomo usa il confronto di idee che ha come risultato le leggi; la bestia impiega la violenza. Ma laddove le leggi non siano sufficienti, il principe deve saper impiegare la violenza, cioè la parte bestiale. Così scrive Machiavelli: “…Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e’ mezzi saranno sempre iudicati onorevoli e da ciascuno laudati; perché il vulgo ne va sempre preso con quello che pare, e con lo evento della cosa; e nel mondo non è se non vulgo, e li pochi non ci hanno luogo quando li assai hanno dove appoggiarsi.”

Secondo l’Autore, il dovere del principe è dunque “…vincere e mantenere lo stato…” e i mezzi saranno giudicati “onorevoli” e “lodati” da tutti, perché il vulgo, la maggioranza dei sudditi, ignara e passiva, sarà sempre colpita dalle apparenze e dal successo dell’azione. E quei pochi che non giudicano dalle apparenze non riusciranno a imporsi perché la maggioranza ha dalla propria parte l’autorità del principe.
Nel corso dei tempi la tesi esposta da Machiavelli è stata generalizzata con il fine di “vincere e mantenere lo stato” da perseguire ad ogni costo, senza distinzione di sorta circa il mezzo per raggiungerlo. Una tesi che, animando un vivace dibattito ampiamente culturale, oltre che strettamente politico, continua a vivere nel mondo contemporaneo. Con lo stesso Machiavelli che viene giudicato da un lato come un repubblicano amico della libertà; dall’altro, come un nemico giurato dei sani principi della moralità e della religione.
Questa seconda tendenza ha favorito l’elaborazione della corrente di critica alla tesi esposta ne Il Principe nota come machiavellismo e che, tuttavia, riduce e semplifica il reale pensiero del suo Autore. In fondo, la sintesi della ben più ampia portata della frase di Machiavelli, operata in quel “il fine giustifica i mezzi”, appare alquanto banale. Per quanto Machiavelli non mostri certo particolare considerazione per il vulgo, il cittadino comune e popolare, indifferente e di facile adattamento al potere del momento, la priorità dell’attività politica è indicata nel mantenimento del potere, ovvero nella ragione di Stato.

Nel capitolo XV della sua “Storia della letteratura italiana”, dedicato a Machiavelli, Francesco de Sanctis scrive: “Ci è un piccolo libro del Machiavelli, tradotto in tutte le lingue, ‘Il Principe’, che ha gittato nell’ombra le altre sue opere. L’autore è stato giudicato da questo libro, e questo libro è stato giudicato non nel suo valore logico e scientifico, ma nel suo valore morale. E hanno trovato che questo libro è un codice di tirannia, fondato sulla turpe massima che il fine giustifica i mezzi, e il successo loda l’opera. E hanno chiamato machiavellismo questa dottrina.”

Per Machiavelli l’agire umano dipende dalla situazione storica contingente; sicché l’uomo virtuoso, politicamente abile, deve saper cogliere l’occasione buona per affermare il proprio ideale. Anche utilizzando la violenza, cioè la propria parte bestiale. Ciò che può limitare forza e violenza dell’uomo è solo la fortuna (il caso, in senso negativo). Alla fortuna, precisa Machiavelli, va comunque opposta la virtù, la più audace iniziativa umana, non già la provvidenza, la virtù che si fonda sul corretto uso della forza, sia essa politica o militare o economica, non sul diritto, né vieppiù sulla morale.
La scelta dell’azione, operata attenendosi alla “verità effettuale”, è quella che garantisce al principe stabilità. Anche laddove, per arrivare ai suoi obiettivi, il principe debba ricorrere a metodi crudeli e disumani. E quando a mali estremi sono necessari rimedi estremi, il principe deve adottare tali rimedi estremi ed evitare, in ogni caso, la via di mezzo, quella del compromesso che non serve a nulla. Così avviene in natura ed è bene avvenga nella società degli uomini, dove chi ha una chiara conoscenza di tali meccanismi è di conseguenza in grado di dominarla.
La primazia della ragione di Stato legittima, insomma, l’uso della forza, dell’astuzia, dell’inganno, finanche dell’assassinio politico, fattori analizzati da Machiavelli prescindendo da ogni implicazione di tipo morale, ma come puri elementi della realtà politica.
Anche la religione non sfugge ad una tale analisi e questa viene trattata esclusivamente nel suo ruolo di instrumentum regni, cioè come strumento da mettere al servizio del mantenimento dello Stato.

Di certo Machiavelli non è stato il primo, né l’ultimo, risoluto sostenitore della tesi della superiorità della ragione di Stato. Anzi, il problema dell’organizzazione statuale, di quella sociale e, in definitiva, dell’amministrazione e del mantenimento del potere, è stato affrontato in ogni epoca ed in ogni civiltà. Machiavelli, a suo modo e come molti altri autori prima di lui, propone il tentativo di giustificare eventuali azioni scorrette del principe nel momento in cui fossero finalizzate a salvaguardare l’ordine ed il potere dello Stato. Arrivando a concludere come, in presenza di un fine nobile, si potessero accettare anche scelte immorali.
Anche la vita quotidiana ci offre un detto popolare, molto comune, applicazione pratica della tesi di Machiavelli: “mentire a fin di bene”. Con la palese contraddizione che non sempre si coglie: agendo in tal modo, cioè mentendo, pur volendo compiere un gesto altruistico e di asserita nobile apertura, al tempo stesso si pregiudica la sincerità di una persona e la fiducia verso l’altra.
Ci sembra permanga, in genere, una tendenza alla semplificazione operando una scelta, quale che sia; magari ricercando i più disparati argomenti che la giustifichino e la rendano valida. Finanche arrivando a giustificare ogni sorta di comportamento amorale o non etico pur di raggiungere il fine prefissato. Non sembra, invece, che si propenda e ci si spenda con saggezza nel tentativo di bilanciare il fine ed i mezzi per raggiungerlo.
Nell’eterno durevole conflitto, scegliere la via del bilanciamento, sfumando le differenze, mitigando i contrasti, favorendo la ricerca della “terza via”, quella della saggezza – anzi, del lògos, pur in una delle molteplici significazioni possibili –, richiede sforzi maggiori, ma comporta risultati meno mutevoli e soggetti alle variabili del tempo. Perché questi risultati superano le esigenze originate dal momento particolare e, modellate dalla duttilità del confronto, conservano superiore efficacia relazionale.
Nella scelta di metodo e mezzi per raggiungere il fine, si trascura l’elemento della responsabilità. Non quella soggettiva e personale che “il principe” (come, peraltro, ognuno di noi) compie; ma quella che scaturisce dalle ripercussioni della scelta ben oltre la contingenza, nel medio e lungo periodo. Cuore e fine ultimo della dialettica politica è la ricerca di soluzioni durevoli, non dettate dalla contingenza.
Tra politica, intesa come vita pubblica, e vita privata, non v’è distinzione, ma complementarità e funzionalità, occupandosi la prima della seconda. E nessuno, nella vita privata, all’interno dell’intimità familiare, giustificherebbe metodi amorali pur di raggiungere un fine. Sarebbe – questa certo – scelta cavernicola ed asociale. Piuttosto, va decisamente superata la distinzione e la teoria della “doppia morale”, una per la vita privata e l’altra per la vita pubblica, teoria che smarrisce l’unicità dell’individuo, sempre e comunque in cammino, in ogni momento e senza distinzioni. Non c’è divisione, ma unitarietà tra vita e politica.
La politica è vita e questa, nella sua interezza, risponde delle scelte che, indirizzate eticamente, forse inconsapevolmente, ognuno di noi compie. Ognuno secondo i propri valori etici di riferimento, innati, presenti in noi, arricchiti progressivamente nell’esperienza. Chi slega la politica dalla morale, slega la politica dalla vita. E la vita non può che tenere al suo miglioramento, all’eccellenza, in un continuo cammino, complesso e costante, comune e solidale, ogni giorno ed in ogni momento. Un cammino quasi irraggiungibile, ma per il quale pure ci si adopera. Tendere al miglioramento, all’eccellenza, è fine nobile; i mezzi da utilizzare richiedono equilibrata corrispondenza. Il machiavellismo, allora, si contrasta ponderando adeguatamente mezzi e strumenti a propria disposizione unitamente al fine auspicato. Perché nessuno si sognerebbe di raggiungere le Americhe con qualche sgangherata barchetta in mancanza di meglio equipaggiate caravelle.

Mezzi e strumenti di vita ne abbiamo in abbondanza. Uno soprattutto, primo ed essenziale, ma talmente consueto ed abituale, del tutto comune ed ordinario, da scomparire nella nostra distratta indifferente normalità: l’azione. La più piccola, solo apparentemente banale ed irrilevante azione, è il mezzo per arrivare a quello che si vuole. Quasi invisibile rispetto all’incedere vorticoso della vita, l’azione è il mezzo della vita, cioè il binario sul quale il treno della vita scorre e – come ammoniva un grande studioso del diritto – cui nessuno bada, come se non avesse realtà per sé. Il viaggiatore, protagonista del viaggio della vita, pensa al luogo che lascia e al luogo a cui va; ma al binario su cui scorre il suo muoversi, che collega i due luoghi, che è proprio il segreto del muoversi e che lo consente, resta indifferente, come se non esistesse.
Che peccato. Presi dal meccanicismo della quotidianità, smarriamo di valorizzare ciò che meglio ci consentirebbe di vivere e guardare al fine da raggiungere. Smarriamo l’azione, mezzo di realizzazione della intera vita, consentendo di aggiungere ad ognuno qualcosa di sé sia a sé stesso, sia a ciò che lo circonda, in un continuo percorso di produzione di ricchezza di esperienza. Se si smarrisce l’azione, si smarrisce l’agente, si smarrisce la vita, si smarrisce il fine da raggiungere, qualunque esso sia.
Interrogativo o soluzione, quel “il fine giustifica i mezzi” si supera valorizzando l’azione, mezzo superiore a disposizione del soggetto agente per adeguare sé stesso alla vita.
Un interrogativo, però, per ognuno, per ogni soggetto, resta, sempre irrisolto: “Tu, che azione sei? Cosa fai?”. E la risposta non riguarda il fine, ma attiene proprio al mezzo, ai suoi limiti, alla sua funzionale efficacia, alla sua adeguata ragionevolezza.

(pubblicato nella rivista “Vivere In”, 6/2024, pagg. 7 – 11)