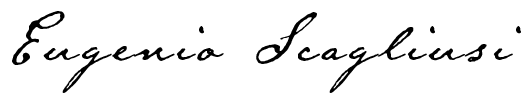“Dante oltre la selva”

Potremmo tutti convenire che la vita possa intendersi – certo, tra tanti altri modi – come un’avventura, alla continua ricerca di un obiettivo, una meta, un’aspirazione, un sogno da raggiungere. Ma chissà in quanti, anche tra coloro che, con studi classici, abbiano letto La Divina Commedia, abbiamo mai pensato, nella quotidianità, come questo testo costituisca un efficace specchio della natura umana, sempre in lotta e dibattuta tra grandezza e misera, tra scelte e relative conseguenze, tra smarrimenti e sempre nuovi entusiasmi. Smarrimenti che, come rilevano Mimmo Belvito e Domenico Modista, autori del breve saggio Dante oltre la selva, avvengono per ragioni disparate: malattie, lutti, delusioni, calunnie, affetti, solitudini, crisi, paure. Tuttavia, ogni momento di crisi fortifica e rende nuovi e la vita in effetti è un viaggio dall’andamento ora lento, ora spedito; con soste e con ripartenze; ed “…in fondo ad ogni crisi c’è sempre uno sbocco di luce…”.
Dante ha consegnato al mondo intero il suo punto di vista attraverso la sua più famosa opera; gli Autori di Dante oltre la selva ci partecipano il loro, così rendendo il capolavoro letterario dell’Alighieri occasione di particolare intima introspezione.
Ogni uomo si trova nel bel mezzo della propria esistenza che non ha voluto o scelto, scoprendosi giorno per giorno come un inquieto homo viator. Ci sembra quasi che gli Autori propongano un percorso di preghiera, di cui La Divina Commedia diventa originalissimo strumento. E se mai il termine “preghiera” possa non essere gradito ai non credenti, esso può benissimo cassarsi, mantenendo il solo “percorso” o, meglio – come gli Autori stessi precisano – “cammino” verso qualcosa che si desidera. Siamo tutti in cammino in questo viaggio della vita ed anche “…quando ci sentiamo deboli, incapaci, indegni, non dobbiamo mai abbandonare il desiderio di arrivare a un punto. Dante ci insegna questo: se non ce la fai, se ti mancano le forze ma una cosa la desideri, sarà proprio il desiderio la tua forza e la tua leva.” Anche nei momenti di massimo smarrimento, c’è sempre la possibilità di riprendere il cammino, che sia con l’aiuto della ragione di un qualche buon Virgilio o con il superiore aiuto della pace del cuore, la Grazia rappresentata da Beatrice.
Il tema del viaggio, non solo quello letterario e spirituale di Dante, ma di ogni uomo nella storia, costituisce il fulcro di questo saggio; non secondo, anzi quasi parallelo, il tema dell’amicizia, in tutte le sue declinazioni, che si nutre anche dell’umiltà nel saper riconoscere i propri errori e farne occasione di ricostruzione dei fragili rapporti umani attraverso l’incontro con l’altro.
Dante si riconosce umile e raccomanda umiltà. Un po’ novello Ulisse, suggestionato dall’orgoglio intellettuale di poter raggiungere la verità con le sole sue forze, proprio come l’eroe omerico anche Dante compie un viaggio. Con la differenza che “…Ulisse, pagano, ha esplorato l’ambito naturale e fisico; Dante, cristiano, ha proseguito oltre grazie alla verità rivelata da Dio che illumina ogni mistero…”.
Nessuno si salva da solo. E la destinazione ultima del viaggio è rappresentata dalla consapevolezza che la più alta, nobile e somma espressione dell’amicizia è l’Amore, quello che tutto muove, asse portante di tutta la maggiore opera dantesca.
Il testo propone una efficace sintesi della vita di Dante, pienamente calato nel suo tempo, famoso ed acculturato, preso tra le sue passioni (anche di uomo innamorato), i suoi studi, gli interessi politici e militari. Anch’egli ferito e smarrito; infangato e limitato nelle sue libertà; ma in cerca di sé stesso. E se la storia di Dante è quella di un po’ tutti noi, gli Autori raccomandano come, pur affidandosi e lasciandosi guidare da ciò che Virgilio o Beatrice rappresentano, occorre pur sempre una decisa scelta di fondo: lasciar andare. Bisogna “…lasciar al passato eventi, persone e situazioni che possono continuare ad agire negativamente su di noi perché diamo loro il potere…”. Ed infine, “…alla Grazia bisogna affidare la vita, affinché, pur tra incertezze ed ostacoli, possa riprendere il percorso verso il fine.” Per Dante la Grazia è il dono partecipato da Dio all’uomo affinché, secondo il proprio libero arbitrio, dunque in piena libertà, scelga la salvezza. L’inizio della vita di “grazia” sta nel “…riconoscere la propria finitezza e la propria insufficienza…”. Non è possibile completare la propria vita con i soli mezzi umani. È la Grazia il vero completamento della ragione e della umana volontà. Non è certo l’unica risposta – precisano gli Autori – poiché si può anche accedere al rifiuto, al rifiuto della vita, producendosi nell’edonismo e nell’immanentismo chiuso in sé stesso, “…così da perdere il fine stesso del proprio esistere…”.
Gli Autori, segnalando come Amore sia l’asse portante della Commedia, annotano l’utilizzo nel Paradiso (nel terzo Cielo, con l’incontro con lo spirito di Folchetto da Marsiglia, Par., IX, 81) del termine intuarsi (“…s’io m’intuassi, come tu t’inmii…”) significando l’amore che entra nel cuore e nella mente dell’altra persona. È così che “…due diventano uno, senza annullarsi nell’altra persona, ma indossando la sua pelle, la sua anima. Significa permettere all’altro di fare lo stesso poiché dire amore è reciprocità. Amare è tendere la mano verso l’altro, entrare dentro l’altro. Se uno ama conosce e solo chi conosce ama…”. L’Amore, insomma, l’agàpe, per dirla con San Paolo (1 Cor., 13), è la via per eccellenza.
Leggere Dante oltre la selva apre ad una profonda riflessione interiore.
Ad ognuno, ad ogni uomo, la sua risposta rispetto al mistero della vita. Gli Autori, con Dante, ne offrono una; peraltro concludendo con la espressa richiesta, ad ogni lettore, di interrogarsi sul personale cammino di vita.
Così, a chi scrive piace concludere queste brevi impressioni con la pregevole annotazione degli Autori: “…In un epoca di superficialità, di relazioni liquide, di sentimenti vuoti, in un epoca in cui ci teniamo sempre a distanza e, se pur connessi, siamo lontani dal cuore delle cose, Dante ci ricorda l’importanza di sentire intensamente, l’importanza di tornare al cuore…”. E non ci sarebbe proprio altro da aggiungere…