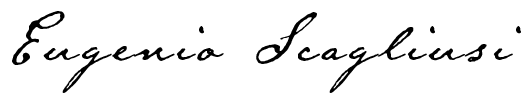La positività, laica certezza di vita

Non è necessario inventarsi nulla. Perché quella della positività è una certezza.
La positività c’è. Esiste. Va solo scoperta, valorizzata, diffusa. Aiutando anche lo scettico a scoprirla.
Ci crediamo. Perché crediamo alla dimensione della vita come dono. L’etica positiva nasce dalla dimensione della vita come dono.
La vita è un dono.
Un dono inaspettato ed in continua evoluzione.
Aprirsi a questa dimensione è semplice: è sufficiente fermarsi e guardarsi intorno.
È sufficiente prestare attenzione alla vita; a ciò che ci circonda; a come la vita si sviluppa intorno ad ognuno di noi; alla straordinaria bellezza a volte offuscata da occhi distratti.
Non neghiamo affatto che esistano fatica, sofferenze, difficoltà. Né ci meravigliamo che esista ciò che chiamiamo “il male”. Ma nel continuo evolversi, sono proprio queste negatività che ci aprono alla speranza, cioè alla forza di proseguire e guardare oltre. Ogni giorno, in ogni momento. Persuasi che, insieme, si possa comunque procedere e crescere.
È necessario farlo tutti insieme. Perché la vita di tutti è veracemente dono per tutti. Nessuno vive per sé stesso. Prendere coscienza della vita, di volere pienamente la vita, conduce alla necessarietà di farsi reciprocamente dono per l’altro; così come la vita stessa, in sé, è un dono.
Ciò che ci meraviglia, piuttosto, è che non ci si avveda come tutto quanto ci circonda sia bello, buono, amabile. Una certezza che può risultare sia da una tesi speculativa, sia dall’osservazione pratica.
Tutto è bello, buono, amabile.
Questa etica positiva consegue dall’idea di sacralità cosmica: l’intero universo, il tutto, è segno e tempio materiale del Lògos, Sommo Bene da cui tutto origina e trae forza, senza del quale nulla è possibile, fonte inesauribile di sapienza, felicità, amore, positività infinita.
Il caleidoscopio di persone, condizioni, luoghi, immagini, colori, situazioni, profumi, presenti ovunque e che accompagnano la vita, sono segni visibili e concreti di una bellezza che sempre stupisce.
In verità, tesi speculativa ed osservazione pratica sono strettamente collegati.

Se partiamo dalla prima e, con essa, ci apriamo alla illuminata lezione dei Padri, in particolare di Giustino, che ha invitato a cogliere la presenza dei germi del Lògos (lògos spermatikòs), i semina verbi, sparsi ovunque, dappertutto, in ogni cultura, nell’intero universo, cogliamo ovunque scintille che, colte, scoperte, ricomposte, collegate, sviluppano esplosioni di ricchezza totalizzante.

I Padri hanno reinterpretato il pensiero e la cultura dominante del tempo alla luce della novella evangelica. Seguendo la loro lezione, ricordiamo come per Platone la sofìa, la sapienza (che nei Padri coincide con il Lògos) nasce come amore di bellezza e nel Fedro afferma che la bellezza, che sta dall’altra parte del cielo, è qui, presente in terra, ben visibile. Platone non dice com’è arrivata, ma afferma che è qui discesa. E chiama questo movimento amore.
Cercare bellezza.
Ecco, allora, che dovremmo imparare a ricercare il bello. Perché c’è. Infinito. Basta cercarlo. Saperlo cercare. Amando. Imparando ad amare e valorizzare anche le piccole cose.
Oggi, più che mai, c’è bisogno di educarsi a cercare bellezza.
Proponiamo la ricerca e la valorizzazione della bellezza, della grazia, della eleganza, del fascino; delle tante cose belle che ci circondano ed animano la nostra vita, la vita di tutti quanti noi. Peraltro ben consapevoli che finanche nelle piccole cose si trovino le grandi, le meravigliose.
La sfida dell’oggi è provare a proporre l’attenzione per la bellezza; riscoprire come tutto, ogni cosa, sia intrisa di bellezza; in tutto, in ogni cosa, sia presente il segno della “bontà”.
Un po’ richiamando il poeta tedesco Friedrich Hölderlin, dovremmo imparare ad abitare poeticamente la terra. Non limitandoci, però, a farne una sfida poetica, ma considerandola sfida di vita, nella quale siamo presenti, creature del gran libro di un mondo bello, adatto anche a chi non sa leggere né scrivere, secondo una metafora di Agostino d’Ippona.
In fondo, per apprezzare il dono della vita, il suo valore, la sua straordinaria bellezza, non servono paroloni. Tanto che non avremmo mai pensato che questo percorso, questa sfida di vita, la sfida di cogliere la bellezza e la positività della vita, la vita come dono, facendo emergere questa etica dall’osservazione della vita stessa, dal saper cogliere la vita stessa; ebbene, questo percorso possa essere agevolato attraverso il testo di una canzone.
Sì, anche una “sana laicità” può essere utilissima. Anche quella di Riccardo Pazzaglia, autore del testo di Meraviglioso, cantata da Domenico Modugno. “Ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso… Perfino il tuo dolore potrà guarire poi, meraviglioso… Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto: ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente. Ti sembra niente il sole, la vita, l’amore… Meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te…la luce di un mattino, l’abbraccio di un bambino, meraviglioso… La notte era finita e ti sentivo ancora, sapore della vita…”
https://www.youtube.com/watch?v=SRzg6DzIxzg
Il gusto della vita.
Ad essere meraviglioso è l’intero sapore, il “gusto”, della vita.
Questo testo sarà pure “laico”; ma potrebbe diventare – per chi volesse – finanche una efficacissima preghiera.
Lo stesso può dirsi per un’altra canzone, resa famosa nello stesso periodo (1967 – 1968) da Louis Amstrong, What a wonderful world.
“Vedo alberi verdi, anche rose rosse. Le vedo sbocciare per me e per te. E fra me e me penso, che mondo meraviglioso. Vedo cieli blu e nuvole bianche. Il benedetto giorno luminoso, la sacra notte scura. E fra me e me penso, che mondo meraviglioso. I colori dell’arcobaleno, così belli nel cielo. Sono anche nelle facce della gente che passa. Vedo amici stringersi la mano, chiedendo ‘come va?’ Stanno davvero dicendo “Ti amo”. Sento bambini che piangono, li vedo crescere. Impareranno molto più di quanto io saprò mai.
E fra me e me penso, che mondo meraviglioso. Sì, fra me e me penso, che mondo meraviglioso.”
https://www.youtube.com/watch?v=SRzg6DzIxzg
In questa sfida, si potrebbe citare addirittura e persino Friedrich Nietzsche (filosofo fortemente critico nei confronti della religione ed in particolare del cristianesimo), che fa esclamare al suo Zarathustra, nel Discorso dell’uomo superiore, la frase: “Come è ricca questa terra di piccole cose buone, perfette, ben riuscite!”
Tornando indietro nel tempo…

Tornando indietro nel tempo, potremmo anche riferirci al poeta latino Orazio ed al suo invito (il famoso carpe diem, quam minimum credula postero, sempre banalmente e malamente interpretato) a godere ed apprezzare ogni giorno tutto quanto il bene che la vita ci offre.
E potremmo soprattutto riferirci alle sensibilità dei lirici greci, con la sostituzione del pregresso ideale epico, del valore del guerriero, della gloria, con la nuova passione per la vita, nel suo intero svolgimento. Una passione che anima ogni aspetto della vita… Finanche i suoi risvolti civili, affinché si possa essere utili per la città: la passione e l’amore per la vita non più fine a sé stessi, ma al servizio del bene comune.
Così per Bacchilide ed Archiloco, con il loro comune auspicio di superare le pur esistenti difficoltà della vita attraverso la necessità di compiere comunque il proprio lavoro, quale che sia, superando ogni rassegnazione. Ed ancora, in Archiloco, con il suo invito a godere la vita finché dura. Non un godimento fine a sé stesso; non una ricerca di eccessi; non un avanzare pretese. Bensì la valorizzazione della vita nella cura delle cose più belle: l’amore, l’amicizia, la bellezza.
Così per Ibico, che trova una bellissima icona della vita nel fiorire della primavera.
Così Alcmane, con i suoi uccelli, con le sue estasi paniche e dionisiache.
Così per Saffo, che – come prima non era mai accaduto – distingue l’amore in sé, dal “ciò che uno ama”. Non l’amore, ma ciò che l’amore suscita in ognuno di noi. L’amore che si relativizza, diventa soggettivo, diventa desiderio e piacere di bellezza. L’amore che vive attraverso la contemplazione di tutto ciò che è buono e bello. Buono e bello che arrivano a coincidere: tutto ciò che è buono è anche bello. Non sono tanto importanti i valori personali ma l’uomo in sé, con le sue passioni e le sue debolezze; quanto di buono, di bello, di vero, di giusto, di ideale di vita un uomo può rappresentare. Lo stesso vale per le cose; per tutte. Per tutto quanto ruota intorno alla vita di ogni uomo. Dunque, per la vita stessa.
Così per Alceo, fautore della bellezza della vita in comune; cantore del piacere del simposio quale occasione di incontro e di dialogo, dell’importanza delle discussioni amicali come ispiratrici di decisioni da prendere. Affinché le condotte siano, poi, le migliori; anche per il bene comune. Affinché questo metodo consenta di superare l’indifferenza per le sorti della comunità cui si appartiene.

Così in tutti i lirici, che propongono tutti un amore per la vita all’insegna dell’aristòn, del bene più grande, che proprio perché si confronta con limiti inconoscibili, va continuamente ricercato, desiderato e, per quello che è possibile, anche tragicamente conquistato. Una proposta, una filosofia di vita, una scelta: quella tra una vita piatta, tranquilla, senza ebbrezza né voli, e una vita in cui le passioni ardono sempre, ma devono costantemente ritrovare la loro misura. Passioni non solo attinenti alla vita privata, alle personali vicende sentimentali, ma coinvolgenti tutta la vita: politica, sociale, culturale, religiosa, che non dovrà mai acquietarsi in nessuna stagione di essa.
Il grande prodigio che è l’uomo.
Il carattere unitario del pensiero dei lirici greci è nella comune esortazione in favore dell’uomo, che vive il suo impegno di vita familiare, sociale, culturale, tutto al servizio della “cosa più bella da ricercare”: l’amore, la cura per il bello ed il buono. Quasi una missione, un servizio di promozione e di educazione ad apprezzare il piacere e la bellezza della vita, dell’amicizia, in prospettiva di un comune miglioramento della qualità della vita stessa, nel suo complesso. Migliorare, con la vita, quel “grande prodigio” (come lo definisce Sofocle nell’Antigone) che è l’uomo stesso.
La grande lezione dei lirici greci sta nella mancanza di distinzione tra i vari momenti della vita. Non singoli episodi distinti, come il lavoro, il mangiare, il dedicarsi ai propri hobbies, diremmo oggi; ma un continuo vivere politicamente. Una continua scelta di quanto, nei diversi momenti della giornata, si potesse fare di “buono”, di “bello”. Una continua aspirazione alla bellezza, a quell’amore che supera la irrazionalità per diventare prima “amicizia”; infine amore razionale, cioè “dono”. L’amore, l’eros, totalmente radicato nella natura umana, deve poter diventare agàpe, farsi “dono”. Deve poter diventare ricerca di felicità per l’altro. Fino alla dimensione, straordinariamente bella, dell’esserci per l’altro.
Esserci per l’altro.
La vita è bella. Il mondo è bello. Le nostre vite sono bellissime. Vita e mondo lo diventano ancor più allorquando si maturi la lezione dei lirici greci dell’esserci per l’altro. Che avrà pure duemilacinquecento anni, ma è attualissima. Ormai eterna. Ed ampiamente scopiazzata da altre filosofie: le stesse che periodicamente provano a relegarla in soffitta, tra le cose più vecchie ed inutili.

Una lezione diffusa con vigorosa convinzione anche da Fëdor Dostoevskij, tra i più grandi estimatori della bellezza, che nel suo libro L’idiota scrive con vigore la famosa frase: “La bellezza salverà il mondo”. Una certezza che l’Autore deriva proprio dalla lezione dei lirici greci del kalòs kai agathòs, la poetica globale del bello e buono, qualità non solo estetiche, ma che si riferiscono altresì alla perfezione morale ed alla grandezza della persona umana.
Se, poi, questa lezione non dovesse soddisfare, si potrebbe proporre quella di un altro filosofo, Immanuel Kant, che nella sua Critica del giudizio spiega come ad ogni uomo, attraverso l’osservazione, è offerta la possibilità della contemplazione. L’uomo, così, riconosce i limiti della sua razionalità e si apre alla possibilità di una dimensione sovrasensibile, percepita attraverso le sue stesse emozioni suscitate dall’osservazione.
Circondati da bellezza e positività.
Insomma, calarsi nella vita, che sia osservandola con attenzione; che sia a mezzo introspezione personale; che sia affidandosi ai pensatori ed alle culture più disparate presenti nella storia dell’umanità; in ogni caso, questo lavoro di ricerca ci conduce a concludere che siamo circondati da bellezza e positività.
In questo, forse, la difficoltà maggiore. Perché si corre il rischio di abituarsi – troppo e pericolosamente – a tanta bellezza e positività. Ci circondano, infinite. Ovunque. E forse se non ce ne accorgiamo è perché… non siamo sintonizzati sullo stesso canale.
Si può anche essere circondati da bellezza e positività; ma se non si è vitali di fronte a tutto ciò, se non si è predisposti, se le due condizioni non sono presenti in noi, noi non le percepiamo.
Ecco, allora, che la sfida più grande, ben più complicata del proporre l’attenzione per la bellezza, che nasce in modo naturale dalla vita, è di rendersi belli e positivi interiormente, così da arricchire la vita stessa, dono unico e prezioso.
Questa vita che ci è stata donata, come la vigna della parabola, va curata, così da poter trarre da esse tutto il buono, il vero, il bello che è in grado di produrre. Anche nei momenti più difficili e disperati. Anche in quei momenti, con vero sguardo contemplativo, si possono cogliere elementi di positività. Dunque, il segreto del creare positività in ogni condizione della quotidianità sta nel vivere, sempre ed in ogni momento, con sguardo contemplativo che nasca, sincero, dal più profondo del nostro essere. È il nostro ideale di vita; un ideale che diventa certezza.
(pubblicato nella rivista Vivere In, 1 – 2025, pagg. 9 – 14)