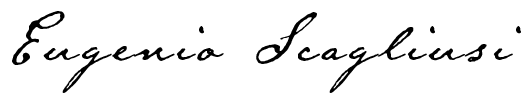Nei licei, oltre il docente, l’educatore al bello e al positivo

Un docente così è desiderio di ogni studente liceale. Severo, ma giusto. Nessuno ricorda di insufficienze non meritate; piuttosto, molti ricordano quanto fosse attento nel premiare i più volenterosi, a volte anche prescindendo dalle conoscenze manifestate durante le interrogazioni.
Gran conoscitore e dominatore delle materie di insegnamento, quelle lingua e letteratura greca e latina che gli consentivano lo studio diretto delle sue fonti preferite: gli scritti dei Padri della Chiesa, occupati per primi a rileggere la dominante cultura classica del tempo alla luce della novità evangelica.
Se si volesse compendiare in poche parole l’aspirazione profonda, il fine ultimo, il desiderio non sempre ben celato del Nicola Giordano professore liceale, si dovrebbe riferire del suo voler trasmettere agli studenti l’insegnamento a cogliere i semina verbi ed i germi della positività presenti nella varie culture, insieme alla scoperta e valorizzazione del bello in ogni contesto; anche nelle occasioni più complicate. Il tutto, mediante la lettura ottimistica dell’intera umana esistenza perché guidata da ciò che spesso chiamava l’Ignoto, l’Incomprensibile, l’Indefinibile, Somma Potenza, Amore.
Ogni docente, anche il più brillante e preparato, ha i propri argomenti preferiti. Gli studenti lo percepiscono dalla diversa passione che emerge rispetto alle lezioni più comuni. Ci sono occasioni in cui quella predilezione compare, per quanto in maniera più o meno palese.
Tutti gli studenti del professor Giordano ricordano le sue spiegazioni del kalòs kai agathòs attraverso la lirica greca, il riferimento ad un idea di bellezza che, anche superando l’originario valore guerriero, giunge alla valorizzazione del comportamento morale, oltre al bello nel suo aspetto sensibile. Una valorizzazione estesa all’universo intero, manifestazione di supreme bellezza e perfezione.
Solo uno studioso innamorato dei Padri ed esperto di Lectio Patrum come il professor Giordano avrebbe potuto e saputo far cogliere ai giovani studenti, senza alcun appesantimento didattico, tantomeno confessionale, il collegamento culturale tra Venus genetrix, la laica genitrice del genere umano di Lucrezio, principio vitale della continuità dell’esistenza, portatrice di pace, e la Theotokòs, la Madre del Dio fatto uomo, figura materna e solidale di tutta l’umanità, titolo usuale nella scuola alessandrina, a lui tanto cara.
Solo quel docente avrebbe potuto e saputo far cogliere a quei giovanotti, a volte apparentemente svogliati o disinteressati, il tormento presente nell’epicureo Lucrezio, materialista convinto, preso tra il bisogno di infinito prepotentemente presente nel suo intimo, e la finitezza di ogni cosa.
Solo quel docente avrebbe potuto e saputo presentare Lucrezio come il primo inconsapevole cercatore di infinito, in grado solo di intuire ciò che sarebbe stato più chiaro in Agostino, nel suo “…è inquieto il mio cuore, finché non trova pace in te, o Signore…”. Perché quell’oscuro malessere che Lucrezio percepiva, il cogliere la fragilità della vita, l’inquietudine che in essa irrompe anche nei momenti di piacere, non è altro che il bisogno di infinito avvertito dall’uomo nella sua consapevole finitezza.
Così, quel docente, pur facendo innamorare i suoi studenti della cultura classica, ha saputo esporre loro, come solo un protagonista o testimone potrebbe, che c’è stato un momento, nel tempo, in cui un avvenimento, l’incarnazione, ha costituito il superamento rivoluzionario proprio della sapienza greca dominante, così obbligando ogni cultura successiva a confrontarsi con quell’avvenimento.
Quel dato rappresenta il punto di partenza di una prassi, di un etica di vita completa, di una antropologia, che vive ed ispira a tutt’oggi le condotte di chi, ogni uomo, sente la responsabilità dell’essere pienamente calato nella storia e prova ad esserne parte, attore, artefice, protagonista, senza subirne passivamente le dinamiche.
Chi ha avuto la fortuna di frequentarlo ed ascoltarlo oltre il periodo scolastico, ha potuto comprendere meglio ed approfondire queste prerogative. Chi, invece, non ha avuto quella fortuna, ha comunque conservato la passione per la classicità.
La lezione del docente Giordano non è affatto diversa da quella del sacerdote, biblista, patrologo, Giordano: è nella storia, anche nelle sue evoluzioni culturali, che possono incontrarsi e cogliersi i segni del divino.
Nel ricordo di chi scrive, l’affidamento, in vista dell’esame di maturità classica, di uno studio sul tema del bello e dell’amore nel raggio della classicità, con letture specifiche dai lirici greci, dai tragici, ma anche da Catullo, Lucrezio e Orazio.
Dopo l’ultima lettura, nell’ormai lontano Giugno 1983, l’invito a rileggere meglio l’Antigone di Sofocle. “Forse adesso è ancora presto – mi disse – però, se vorrai, partendo da quel testo potrai approfondire non più i tanti modi di intendere il sentimento amoroso, quanto l’amore quale strumento per superare la rigidità dell’obbligo giuridico rispetto all’obbligo morale.”
Come ogni studente, in quel momento ci capii poco o nulla. Poi si aprirono le porte della facoltà di Giurisprudenza. Ed ancora oggi, dopo più di trentacinque anni, quel docente mi induce a studiare ed indagare nel profondo il fenomeno giuridico, al tempo stesso genesi e sintesi della politica, della storia e della unitarietà della vita.
Ma questa è, appunto, un’altra storia…O sempre la stessa, come forse Lui penserebbe: la Storia.
pubblicato nella Rivista bimestrale Vivere In, n. 2/2019
numero speciale dedicato al fondatore, don Nicola Giordano, nato al cielo domenica 17 Marzo 2019