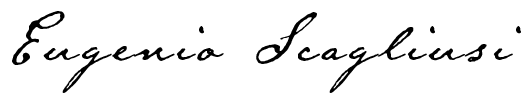Una legge per il fine vita

Il dibattito sul tema del fine vita e dell’aiuto al suicidio è stato ravvivato da ben due recenti sentenze della Corte Costituzionale, la numero 66 dello scorso 20 Maggio e, come se ancora non bastasse, la numero 132 del 25 Luglio.
Riassumendole in breve, con la prima la Corte ha ritenuto non discriminatorio limitare, per i pazienti che già necessitino di un trattamento di sostegno allo scopo di assicurare loro le funzioni vitali, la possibilità di accedere al suicidio assistito.Già con pronunzie precedenti (soprattutto la n. 242 del 2019) la Corte aveva indicato quello del trattamento di sostegno vitale come una delle condizioni in presenza delle quali la condotta di aiuto al suicidio potesse ritenersi non punibile.
Con la seconda, sia pur incidentalmente, la Corte sembra affermare il diritto, per i pazienti che versino nelle condizioni patologiche su indicate, di essere “accompagnati” dal Servizio Sanitario Nazione nella procedura di suicidio medicalmente assistito, indicazioni che illustri esperti giuristi hanno giudicato contraddittorie rispetto a quanto la Corte aveva statuito appena due mesi prima, nonché ingerenti le prerogative di scelta legislativa riservate al Parlamento.

Come in passato, con la sentenza n. 66/2025 la Corte ha riconosciuto al Legislatore un significativo margine di discrezionalità “…nel bilanciamento tra il dovere di tutela della vita umana, discendente dall’art. 2 Costituzione, e il principio dell’«autonomia» del paziente nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona…”, margine di discrezionalità cui in qualche maniera occorrerà avvalersi. Ed in effetti l’esigenza di tutelare la vita di ogni individuo, confermata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 13.06.2024) quale preciso dovere dello Stato, anima il dibattito politico in Parlamento, nel quale sono presenti le sensibilità più disparate cui competerebbe individuare “…le condizioni per accedere al suicidio assistito, dato che se questo, per un verso, amplia gli spazi riconosciuti all’autonomia della persona nel decidere liberamente sul proprio destino, crea – al tempo stesso – rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, in adempimento del dovere di tutela della vita umana che, esso pure, discende dall’art. 2 Costituzione…”.
La seconda sentenza, la n. 132/2025, invece, sembra confondere, nelle competenze riservate al Sistema Sanitario Nazionale, la verifica delle modalità di esecuzione della procedura di suicidio medicalmente assistito con l’accompagnamento e l’ausilio” nell’impiego dei mezzi, affermato per la prima volta, così trascurando come tra “verificare” e “aiutare” vi siano importanti differenze, sostanziali, linguistiche ed ontologiche.
Insomma, se con la prima sentenza si sollecitava nuovamente il Legislatore ad intervenire sulla materia, in piena autonomia e discrezionalità, operando un equo bilanciamento tra autodeterminazione della persona e dovere di tutela della vita umana (“…bilanciamento nell’operare il quale il legislatore deve poter disporre, ad avviso di questa Corte, di un significativo margine di apprezzamento…”, come si legge al par. 7, sentenza n. 66/2025), con la seconda sentenza sembra volersi indirizzare il Legislatore verso il riconoscere un vero e proprio diritto di morire, finanche a prescindere dalla verifica della sussistenza delle condizioni patologiche.

Se in materia così delicata ci si auspicava decisamente maggiore chiarezza, anche con maggiore rispetto delle diverse competenze e prerogative tra potere legislativo e potere giudiziario, l’aspettativa è decisamente tradita.
La sentenza n. 66/2025 ben manifestava la preoccupazione di prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili richiamando “…il rischio che la richiesta di accesso al suicidio assistito costituisca una scelta non sufficientemente meditata…”. Pertanto, ribadiva come fossero essenziali “…le esigenze di tutela delle persone deboli e vulnerabili che danno rilievo alle precise condizioni procedurali costantemente ribadite da questa Corte (sentenze n. 135 del 2024 e n. 242 del 2019, ordinanza n. 207 del 2018)…”, incluso il pre-requisito della “…messa a disposizione di un percorso di cure palliative…”, infine affidando al Servizio Sanitario Nazionale “…un disinteressato accertamento della sussistenza dei requisiti…”. Tutto questo, al fine di contrastare “…derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso…”.
Si trattava di precisazioni di assoluta importanza, che la stessa Corte legava all’attuale contesto storico, “…caratterizzato da tensioni sull’allocazione delle risorse pubbliche…”, con il rischio che il diritto di morire, come “…rivendicato in alcune circostanze, potrebbe essere paradossalmente percepito dal malato come un «dovere di morire» per non «essere di peso», con un grave abbassamento della sensibilità morale collettiva che tutela le persone più fragili, spesso, peraltro, «invisibili»…”. Massima la cura e l’attenzione verso la particolare condizione di queste ultime, spesso “…persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita qualora l’ordinamento consentisse a chiunque di cooperare, magari per ragioni di personale tornaconto, all’esecuzione di una loro scelta suicidaria…”.
Peraltro, la Corte non mancava di bollare tali “derive sociali e culturali” come uno “…scivolamento…” che “…colliderebbe frontalmente con il principio personalista che anima la Costituzione italiana”, dal quale deriva, invece, “…il dovere della Repubblica di rispondere all’appello che sgorga dalla fragilità, in modo che una persona malata possa avvertire la solidarietà attorno a sé non a tratti, non a prolungate intermittenze, ma in via continuativa, attraverso un percorso di effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale…”.
Per queste ragioni, la Corte concludeva raccomandando al Legislatore di “…garantire adeguate forme di sostegno sociale, di assistenza sanitaria e sociosanitaria domiciliare continuativa, perché la presenza o meno di queste forme di assistenza condiziona le scelte della persona malata e può costituire lo spartiacque tra la scelta di vita e la richiesta di morte…”.

Alla richiesta di morte, i giudici costituzionali rispondevano raccomandando l’esigenza del “prendersi cura” garantendo un accesso universale ed equo alle cure palliative nei vari contesti sanitari e, così, rinnovando l’appello al legislatore “…affinché dia corso a un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative e di una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociosanitario, al fine di evitare un ricorso improprio al suicidio assistito…”.
Se questo è quanto si legge nella motivazione della sentenza n. 66/2025, quanto si legge, invece, nella sentenza n. 132/2025 appare quasi incomprensibile, se non attraverso le sottili analisi riservati ai tecnici operatori del diritto, in grado di apprezzare le differenze tra le motivazioni vere e proprie di una decisione e quelle meramente incidentali, cioè non strettamente decisive rispetto al caso in esame (nel linguaggio giuridico, gli obiter dicta) e non vincolantie che, nel caso specifico, si aggiungevano alla declaratoria di inammissibilità (per ragioni processuali, più che sostanziali) di una eccezione di incostituzionalità sottoposta alla Corte.
In questo contesto, la nostra preoccupazione – ben oltre le decisioni della Corte Costituzionale – è proprio per il dibattito politico che riguarda la materia del fine vita e che vede il Parlamento impegnato nel suo compito istituzionale di legiferare.

Esiste un vuoto legislativo che va colmato superando anni di indecisioni solo in parte giustificabili dalla complessità dei problemi, etici, medici, tecnologici, che si aprono dinanzi alla materia del fine vita. La difficoltà sta soprattutto nel superare le più comuni, stanche, inutili e banali impostazioni e contrapposizioni ideologiche, mantenendo invece come unico riferimento il principio fondamentale che regge il nostro impianto costituzionale: il principio personalistico al cui apice sta il diritto alla vita di ogni persona. Principio laicissimo e certo non confessionale, che può declinarsi sì in vari modi, prescindendo da valutazioni proprie di una o di altra parte politica, ma che – riteniamo sommessamente – debbano primariamente cautelare e garantire, per l’appunto, la vita (con essa, le necessarie cure palliative nel suo momento finale), non certo la morte.

Qualsiasi intervento che valga ad allontanare la vita, favorendo in qualche modo la morte, mascherando quest’ultima scelta nella esaltazione della libertà individuale, ci sembra disumano. Quasi un deprecabile ritorno alla irrazionalità che, tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX, veniva mitizzata nel superomismo di Friedrich Nietzsche, che nel suo Crepuscolo degli idoli scrisse che, in certe condizioni, è indecente vivere più a lungo, allorché l’esistenza ha perso ogni significato. Una dimensione individualistica e materialistica della vita oggi pericolosamente riemergente in alcune culture e che ci sentiamo decisamente di opporre rispetto ad un approccio solidaristico e spiritualistico, ben più confacenti la natura e la dignità della persona umana.
Sì, ci opponiamo alle culture eutanasiche, che vorrebbero garantire un diritto di morire rispetto a quello di mantenere in vita una persona finanche quando la sua vita sia irrimediabilmente compromessa. Del resto, siamo tutti ben consapevoli di quanto la vita sia un bene fragile e, dunque, appare veramente incomprensibile ed irrazionale che si dubiti dell’essenzialità della sua cura. In ogni contesto, situazione, condizione, livello.
pubblicato in rivista “Vivere In”, 4-2025, pagg. 13 – 17
per approfondimenti, sentenze della Corte Costituzionale nel link
https://www.cortecostituzionale.it/contenuti/rapporti-cittadini/pagine-tematiche/fine-vita