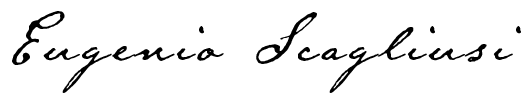Tornare a Camaldoli, chiamata all’assunzione di responsabilità
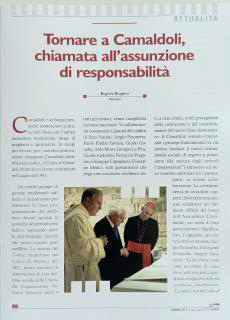
Camaldoli è un borgo pressoché sconosciuto ai più, se non fosse per l’antico monastero medioevale, luogo di preghiera e spiritualità. In tempi più recenti, per i cattolici politicamente impegnati Camaldoli identifica un codice, il Codice di Camaldoli, frutto di un lavoro cominciato nel Luglio del 1943.
Un nutrito gruppo di giovani intellettuali cattolici si incontrarono per elaborare le linee programmatiche che avrebbero dovuto ispirare le politiche del periodo post bellico, superando quelle dell’ideologia fascista che aveva causato quel conflitto.
La stesura del Codice, modellato sul Codice di Malines del 1927, primo tentativo di elaborazione di una dottrina sociale della Chiesa che l’organizzatore Vittorino Veronese spedì a tutti gli invitati, venne completata nei mesi successivi. Vi collaborarono economisti e giuristi del calibro di Ezio Vanoni, Sergio Paronetto, Paolo Emilio Taviani, Guido Gonella, Aldo Moro, Giorgio La Pira, Giulio Andreotti, Ferruccio Pergolesi, Giuseppe Capograssi, Giuseppe Medici, tutti giovanissimi che negli anni successivi sarebbero stati, a vario titolo, umili protagonisti della costruzione e del consolidamento del nuovo Stato democratico.
A Camaldoli vennero concordati i principi fondamentali su cui doveva fondarsi il nuovo ordinamento sociale; di seguito si procedette alla stesura degli articoli (“proposizioni”) attraverso un ricco scambio epistolare tra i partecipanti, in intima collaborazione. La corrispondenza ne consolidò i rapporti, favorendo una operosa solidarietà nei momenti difficili dei lavori dell’Assemblea Costituente, cui molti di loro parteciparono. Significativa, a riguardo, una lettera dell’economista Sergio Paronetto al dirigente d’azienda Angelo Saraceno: “La tua lettera è stata come un’ondata di acqua fresca sulla mia testa cogitabonda ed ingombra delle più complicate elucubrazioni. Tu, infatti, non hai l’idea di come sia macchinoso questo ambiente romano e di come molto spesso venga la voglia di piantare baracca e burattini e occuparsi di fioricultura e di giardinaggio.”
Il ruolo dello Stato, la centralità dell’uomo, la famiglia, il lavoro, l’attività economica privata e pubblica, le relazioni internazionali, furono i temi trattati ed elaborati secondo due principi: il bene comune e l’armonia sociale. Nel Codice si legge che “…Fine dello Stato è la promozione del bene comune, a cui possono partecipare tutti i cittadini in rispondenza alle loro attitudini e condizioni… Lo Stato non deve sostituirsi al cittadino nel perseguimento del proprio bene, ma deve sempre essere presente una direttiva generale di giustizia sociale, quali la protezione e l’elevazione delle classi meno dotate salvi, ben inteso, i rapporti di giustizia distributiva e commutativa…” . Dunque, una concezione dello Stato giuridicamente sviluppata in quel periodo dagli scritti di Giuseppe Capograssi, secondo cui lo Stato deve rinunciare “…a porsi come realtà totalizzante per farsi articolata struttura di servizio alla persona…” .
Nei principi del Codice si trova finanche la legittimazione della superiorità di quella che comunemente si chiama “obbligazione morale” rispetto alla “obbligazione giuridica”: “…Qualora lo Stato emani una legge ingiusta i sudditi non sono tenuti ad obbedire… Se l’oggetto della legge è immorale, cioè lede la dignità umana o è in aperto confitto con la legge di Dio, ciascuno è obbligato in coscienza a non obbedire…”. Considerazioni che oggi turbano ogni giurista.
Protagonista del nuovo ordine sociale è la persona umana, la cui dignità e centralità guidano ogni scelta, anche in campo economico. Emergono l’esigenza di libertà dell’individuo, l’uguaglianza, la solidarietà quale elemento essenziale in vista dell’obiettivo del bene comune, la distribuzione delle risorse, il riconoscimento della proprietà acquisita attraverso il lavoro, il libero commercio e la libera iniziativa economica secondo giustizia, con l’intervento dello Stato a garantirne la corretta distribuzione. Tutte linee guida che negli anni a seguire avrebbero trovato collocazione nella Costituzione Repubblicana e nelle politiche di sviluppo sociale ed economico degasperiane.
Alla base di quel lavoro, la accalorata esigenza della presenza dei cattolici nella vita sociale, con un impegno di azione ed operatività che li vedesse impegnati nell’agone politico. Una esigenza nutrita filosoficamente ed antropologicamente dal personalismo, comunitario e giuridico, struttura culturale in grado di conciliare le molteplici esigenze relazionali e sociali della persona contro ogni deriva individualistica o libertaria.
Lo scorso mese di luglio il monastero di Camaldoli ha ospitato un Convegno di studi dedicato all’80° anniversario del Codice che ha visto, tra gli altri, la presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del Presidente della C.E.I. Matteo Zuppi, del Segretario di Stato della Santa Sede, Pietro Parolin. Nei loro interventi, l’auspicio di “ritornare a Camaldoli”, cioè di far tesoro del metodo del confronto e della condivisione tra esperienze diverse accettando la parzialità della dimensione politica per ricercare il maggior bene possibile.
I giovani entusiasti protagonisti di Camaldoli non si preoccuparono di confrontarsi con la dottrina tradizionale presente nella Chiesa. Piuttosto, si preoccuparono di tradurre l’insegnamento della Chiesa in analisi e proposte adeguate per quel tempo. Occorreva una visione innovativa che ponesse le basi per una pace duratura e per la democrazia.
Il tempo che viviamo offre elementi di complessità tali che, proprio come all’epoca del Codice, esigono il valorizzare le condivisioni, le costruzioni solidali ed inclusive, superando le tensioni dialettiche e conflittuali. Occorre un ampio ritorno alla partecipazione alla crescita democratica della società civile e delle istituzioni, che allontani i pericoli dell’attuale individualismo. Si tratta, invero, di un individualismo del tutto illusorio, che finisce con l’allontanare la persona dalla libertà sperata e la conduce al mero consumo di sé.
Ora, con le raccomandazioni di Papa Francesco e di Matteo Zuppi, come allora, nelle parole di Pio XII, il tempo impone ai cattolici di uscire dalla passività e di assumere iniziative responsabili, nutrendo la politica attraverso la cultura, cioè allontanando da essa le improvvisazioni, la mancanza di visioni, gli interessi modesti e di facciata, puntando invece alla conoscenza dei problemi ed alla loro durevole soluzione.
Compete alla politica, ricorda spesso Francesco, cercare vie efficaci verso la fraternità universale e la pace sociale.
Ai cattolici si chiede il coraggio, nel rispetto delle diverse sensibilità, di interrogarsi ascoltando e dialogando, in un comune percorso di crescita che rielabori e declini i principi dell’ordine sociale, secondo l’espressione del Codice di Camaldoli.
In questo cammino culturale, alla Chiesa si addice il ruolo di faro accompagnatore, di vigile promozione e di assistenza. Urge una responsabilità civile maggiore che interessi e riguardi tutti, in modo che le diverse sensibilità del tempo presente siano ricondotte all’unità attraverso nuovi modi di fare politica, mediando le complessità della vita pur mantenendo saldi principi, valori e contenuti della fede professata. Servono sì menti attente e preparate, ma anche occasioni di incontro, di formazione, di riflessione comune, sia sui temi civili e sociali, sia su quelli della fede, in modo da strutturare e esercitare quella che viene oggi chiamata laicità del credente.
Pubblicato nella rivista “Vivere In”, 3 – 4/2023, pagg. 25 – 28